| |
La
famiglia sforzesca
Per una migliore comprensione
del periodo che stiamo affrontando è necessario avere dinnanzi il
quadro genealogico degli Sforza:
Francesco Sforza, il capostipite
Alla morte di Filippo
Maria Visconti alcuni intellettuali milanesi, ricchi e circondati da
larga considerazione - i Bossi, i Cotta, i Lampugnani, i Moroni, i Trivulzio
crearono una nuova forma di governo per Milano: l’Aurea Repubblica Ambrosiana.
Ma, nonostante i tentativi per condurre una politica sicura, presto affiorarono
grosse difficoltà: le discordie gravi all’interno, la minaccia dei
Veneziani che si spingevano fin sotto le mura di Milano venendo dalla Brianza.
In tali circostanze i reggenti non trovarono un altro modo se non quello
di affidare il comando supremo militare a Francesco
Sforza. Costui aveva sposato la figlia del Visconti, Bianca
Maria, ed aveva ricevuto in eredità la città di Cremona
ed una forte somma di denari. Nell’armata milanese, al comando dello
Sforza, entrò anche per alcun tempo il capitano Francesco Piccinino,
figlio del più famoso Jacopo. Ma nel suo intimo Piccinino odiava
il comandante supremo, per gelosia di mestiere e per aspirazione alla suprema
carica. E proprio in questo periodo il capitano Piccinino aveva
la sede delle sue truppe in Melegnano. Ma in breve tempo il distacco tra
i comandanti divenne più accentuato: nel segreto dei cuori tutti
aspiravano alla signoria di Milano. Il bene della Repubblica, proclamato
in teoria, fu un grosso pretesto per gli scopi individuali da raggiungersi
fino all’ultimo sangue.
L’assedio sforzesco ed i contrabbandieri
I rapporti tra i politici della
Aurea Repubblica Milanese e Francesco Sforza
andarono sensibilmente deteriorandosi. Uomini politici ed il capitano militare
Carlo Gonzaga avevano segreti contatti con i nemici Veneziani. Quando Francesco
Sforza seppe di questi contatti, voltò faccia: anticipò
i politici milanesi e lo stesso Gonzaga e chiese apertamente ai Veneziani
di trattare una tregua o addirittura un armistizio. Si gridò
al tradimento: Francesco Sforza ormai non era
più il supremo difensore della città di Milano, ma un dichiarato
nemico pericoloso. Gli si tolse il comando, ed al suo posto fu elevato
Carlo Gonzaga. Francesco Sforza reagì
passando all’attacco di Milano aggirando la città con un vasto assedio
territoriale per impedire i rifornimenti effettivi: la linea dell’assedio
andava da Pavia a Melzo e si stringeva sempre più. Era, comunque,
la guerra aperta, anche perchè Francesco Sforza
era ricercato dal governo milanese e su di lui pendeva una grossa taglia.
L’assedio alla città di Milano, dalla parte del sud, fomentò
il fenomeno del contrabbando, cioè la circolazione clandestina delle
merci in violazione delle leggi imposte da Francesco
Sforza. Così il condottiero ribelle si trovò a
dover combattere anche un’altra strana guerra, quella dlele azioni, quasi
tutte notturne, contro i suoi bandi militari. A spalla, con carri
e carretti, lunghe file silenziose passavano sul senterium mediolanense,
il sentiero milanese, portando dai nostri paesi del sud est le merci di
prima necessità a Milano: maiali, sale, carne, olio, formaggi, strutto
e perfino il pane. Evidentemente le provviste che Milano faceva dal nord,
cioè dalla zona di Monza e di Lecco, non erano sufficienti. I nostri
contrabbandieri percorrevano la strada da Sant’Angelo per Melegnano. Giunti
a Melegnano seguivano le strade di campagna costeggiando la Vettabia o
passando attraverso piccoli sentieri. Francesco Sforza
dovette istituire un tribunale contro i contrabbandieri i quali formavano
colonne fino a duecento uomini, guidati da Giovanni Moco, un cittadino
di Sant’Angelo Lodigiano.
La reazione veneziana
Mentre il duca rafforzava il
suo potere, Venezia si accordò con i pretendenti al ducato e formo
una Lega antisforzesca, per punire Francesco Sforza
e la sua temerarietà. Tutta l’Italia si mise in moto nelle alleanze;
ma tutti erano stanchi di guerreggiare. Mentre accettavano in cuor loro
il fatto avvenuto, non volevano essere scartati o tagliati fuori bruscamente
dalle vicende politiche. Anche lo Sforza cercò alleanze che trovò
nei Fiorentini, nei Genovesi, nel marchese di Mantova, nella Savoia, negli
Svizzeri e in Renato d’Angiò fratello della regina di Francia e
che si riteneva re di Napoli, una città che non aveva mai potuto
occupare. I Veneziani erano nel Lodigiano e puntavano su Melegnano,
ma il duca si preparava da mesi ad attenderli: Melegnano era una roccaforte
di primaria importanza, come cintura di difesa capitale per Milano. Lo
Sforza, come dicemmo, aveva mandato il 16 marzo 1452 a Giovanni Cristiani,
capitano e castellano della fortezza melegnanese, la somma di 50 ducati
d’oro per i lavori di difesa al castello; inoltre ordinava una riscossione
anticipata e forzosa della tassa sul sale, ed anche una ordinanza di reclutamento
per avere i bifolchi che dovevano condurre i carri dei buoi, non ai campi,
ma col materiale da costruzione in castello; a questi si dovevano aggiungere
gruppi di manovali e carpentieri. Re Renato, uno degli alleati, giunse
in Melegnano, ed il castellano ne dava l’annuncio al duca. Egli conduceva
un esercito di novecento uomini. La sua azione fu più dimostrativa
che efficace, perchè‚ le cose si calmarono, ed il ducato di Milano
ringraziò re Renato; ma, alla resa dei conti, non ebbe bisogno del
suo intervento.
Il dramma di Drusiana tra gli
intrighi della politica
Francesco
Sforza ebbe undici figli legittimi e ventiquattro figli naturali: tra
questi vi era una certa Drusiana, avuta dall’amica Giovanna di Acquapendente
detta “la Colombina”. Frattanto, nel vasto movimento militare italiano,
lacopo Piccinino, capitano di ventura, già nemico di Francesco
Sforza fino alla pace di Lodi del 1454, era passato al servizio del
re di Napoli, Alfonso che però diffidava di lui, perchè‚
non era stabile alle alleanze ed ai patti, quando scoppiò il conflitto
per la successione al regno di Napoli parteggiò per gli Angioini,
pretendenti al trono contro il re aragonese. Nel 1463 il Piccinino
tornò a servire gli Aragonesi di Napoli nella persona di Ferdinando
I°: anche costui non nutriva eccessiva fiducia nella fedeltà
del condottiero. Difatti il Piccinino si appoggiò al duca di Milano
Francesco
Sforza, il quale gli diede in sposa la sua figlia Drusiana; le nozze
si celebrarono nell’agosto 1464: lei era bella, dolce, elegante nell’effervescenza
femminile dei suoi ventisette anni. Ma venne il dramma e la tragica conclusione.
Francesco Sforza sentiva come molesto, militarmente e forse anche famigliarmente,
la presenza nel ducato di Jacopo Piccinino: lo consigliò, quindi,
a ritornare al soldo del re di Napoli che lo aveva richiamato al suo servizio.
Il viaggio verso Napoli fu un triste calvario: uscì da Milano il
27 aprile 1465, poco convinto di questa manovra tra due potenti; arrivò
taciturno e pensoso fino a Melegnano, sua prima tappa. Poi continuò
l’itinerario fino a Napoli, dove, stranamente, vide entusiastiche accoglienze.
Poco tempo dopo, forse con la complicità dello Sforza, il Piccinino
fu imprigionato e strozzato. Drusiana, che era in stato interessante,
si era messa in viaggio per raggiungere il marito, ed a Pesaro fu convinta
dal cancelliere del duca di Milano, Andrea da Foligno, a rientrare in Milano.
Lo stesso Sforza, duca e padre, scrisse una lettera ad Andrea da Foligno,
per manifestargli i suoi sentimenti: “Respondendo at quanto ne scrivete
del venire de Drusiana con la compagnia merchore proximo da sira ad Marignano
et così poy el dì seguente poso el desinare qua da nuy per
li respecti allegati in le vostre littere dicemo che siamo contenti che
essa vegna con la compagnia al dicto dì ad Melignano ad suo piacere
et così scrivemo per la alligata al nostro castellano lì
chel debij fare apparichiare ai meglio che se potrà quello nostro
castello per lo dormre pur perchè per la venuta di nostri incliti
figlioli da Napoli ne è stato necessario mandare aparichiare ad
Pavia et anche come tu Ser Andrea sey informato ne è bisognato provedere
qua per lo alloggiare de Drusiana donde ne trovamo sforniti de licti et
forsi che ad Melignano non potria alloggiare tutta la compagnia ne parreria
ch’el fosse bene che una parte de la compagnia restasse a Lode per lo dormire,
et poy zobia matina venasse ad Melignano da dicta Drusiana et farli compagnia
al intrare in questa nostra inclita cità...”. Il duca, inoltre,
aggiunse istruzioni al suo cancelliere per le spese necessarie, ed al castellano
del nostro castello per i passaporti e per spedire come staffetta “un cavallaro
battando, quando dicta Drusiana con la compagnia serà montata a
cavallo a Melignano per venire qua accò possiamo mandarli incontra
quelli ne parirà per honorarla “. La lettera fu data in Milano il
4 novembre 1465. Drusiana, entrando in Milano, conobbe la triste
fine del suo marito. Visse in Milano alla morte del duca suo padre; poi
scomparve nell’ombra, entrando in un convento. Ma anche qui non trovò
la pace: il nuovo duca Galeazzo Maria, per interessi politici la costrinse
a passare a nuove nozze. Ma Drusiana fuggì avventurosamente a Trezzo,
poi a Bergamo, quindi a Padova dove morì improvvisamente il 29 giugno
1474.
Melegnanesi al tempo degli Sforza
Anche l’amministrazione sforzesca
incrociò le sue pratiche economiche, politiche e militari con il
contesto di Melegnano mediante l’opera e le prestazioni di alcuni melegnanesi
direttamente interessati: Bonino, uno dei comandanti dell’esercito ducale
ricostruito; Scaramuccia, venne selezionato come milite scelto per essere
inviato presso la duchessa di Savoia; Gotardo, entrò nelle file
dei balestrieri ducali; Matteo, liberato dal carcere di Guastalla per una
concessione straordinaria di amnistia in occasione delle feste pasquali
del 1478; Pietro Cassini, ottenne il permesso di recarsi negli accampamenti
pontifici e quelli di Ferdinando di Napoli per chiarire una questione familiare
ed anche con l’incarico di osservare bene il tipo di organizzazione e la
particolare struttura delle caserme e delle truppe, con l’obbligo di riferire
minutamente agli intendenti ducali milanesi nel più breve tempo
possibile; Pier Maria de’ Rossi, richiese al capitano di giustizia di Milano
di procedere penalmente contro alcuni coltivatori di Melegnano perchè‚
si rifiutavano di pagare grossi debiti per una lite giudiziaria sui contratti
dei fondi rustici.
La questione dei beni
Una clamorosa contesa riguardò
i beni terrieri situati nella Savoia e che erano proprietà prima
dei Visconti e poi passati agli Sforza. Tali beni furono richiesti
dagli antichi proprietari della Savoia, prima con azioni giudiziarie, poi
con minaccia di mettere un’ipoteca su tutti i beni che la corte ducale
aveva in Melegnano. La lite si trascinò per diversi anni sui
banchi giuridici e nelle sedi politiche. Ma le amicizie, le raccomandazioni,
e soprattutto il passaggio e l’offerta di sontuoso soggiorno ai pezzi grossi
della diplomazia italiana misero la corte ducale al sicuro. Nel diario
di Cicco Simonetta, segretario sforzesco, si trova scritto: “EI reverendissimo
cardinale de sancto Sixto, legatus a latere in Italia, hogi s’è
partito et venuto a desinare ad Melegnano, secondo l’ordine dato”, era
il 12 settembre 1473. Il cardinale si chiamava Oliviero Caraffa, abile
diplomatico e politico intrigante, ma potente e temuto.
Le successioni
Sembrava che il dominio sforzesco
fosse ormai del tutto saldo, quando il duca Francesco
Sforza improvvisamente morì l’8 marzo 1466. La moglie Bianca
Maria resse il ducato fino a consegnarlo al figlio ventenne, Galeazzo
Maria. Quando il nuovo duca ebbe il comando, la madre si ritiro in
silenzio. Partì da Milano per Cremona. Si fermò a Melegnano
perchè‚ si sentiva ammalata. E qui, nel nostro castello, morì
all’età di 42 anni il 23 ottobre 1468. Qualcuno insinuò che
la duchessa fosse stata avvelenata e che il figlio ne sapesse qualcosa.
Il nuovo duca ventenne, Galeazzo Maria, sposò la sorella di Amedeo
di Savoia, Bona, una fanciulla meravigliosa che eccitò perfino il
genio di Shakespeare immaginandola fidanzata per breve tempo con il re
Edoardo d’Inghilterra. Inoltre Bona di Savoia era sorella del re di Francia.
Con tale matrimonio erano corretti i disegni del ducato: la Savoia, prima
nemica, ora era amica. Rimaneva sempre l’accanita ostilità dei Veneziani
al punto tale che Galeazzo Maria dichiarò guerra con tanta fretta
che dovette quasi subito smettere e ritirarsi nei suoi confini ducali:
gli altri principi italiani gli erano contro.
Le nuove realtà ducali
tra congiure ed intrighi
 Galeazzo
Maria Sforza tentò di continuare la politica paterna e mantenne
anche buone relazioni con gli alleati, privilegiando la Francia; e non
mancava di buone qualità. Ma, oltre il confronto con l’alta figura
del padre, gli nuocevano i modi superbi e la dissolutezza della vita.
Pesò sul fisco inasprendo le tasse, sbagliò grossolanamente
politica estera con Venezia e con i Fiorentini - era il tempo del famoso
Lorenzo il Magnifico -, non ascoltava la voce dei consiglieri più
quotati: il tutto sfociò in una congiura di nobili milanesi già
suoi amici, ai quali si aggiunsero gli avversari anche per risentimenti
personali. Il duca Galeazzo Maria cadde pugnalato nella chiesa di Santo
Stefano il 26 dicembre 1476. Si riapriva la crisi del ducato. Il suo figlio,
Gian Galeazzo II° aveva sette anni. Rimanevano in vita come
pretendenti i cognati di Bona: Sforza Maria, Lodovico il Moro, Ottaviano,
Ascanio. Lodovico il Moro era il più intemperante, aveva 26 anni,
brillante, furbo, tenace, machiavellico: tutti lo davano come l’aspirante
focoso al ducato, a tal punto che chiese alla vedova, Bona di Savoia,
sua cognata, di aiutarla nel comando e nell’amministrazione: ella acconsentì;
in tal modo i destini si maturavano tragicamente: il segretario Cicco
Simonetta fu decapitato; Bona di Savoia dovette ritirarsi nel castello
di Abbiategrasso; il figlio Gian Galeazzo che era il legittimo duca fu
relegato a vivere la giovinezza nel castello di Pavia, sotto la buona
cospirazione tutelativa dello zio Lodovico il Moro, colui che seppe aspettare
e riemergere dalla frana del ducato. Nel 1480 era l’incontrastato dominatore,
dopo due anni di reggenza collettiva. Lodovico il Moro celebrò
le nozze con Beatrice d’Este, figlia del duca di Ferrara; ottenne il riconoscimento
del titolo di duca dall’imperatore Massimiliano d’Asburgo, ad onore del
quale chiamò con lo stesso nome di Massimiliano il suo figlio primogenito;
mentre procurò al giovane nipote Gian Galeazzo, relegato in Pavia,
un clamoroso matrimonio con Isabella d’Aragona, coltissima ed affascin
ante: i due sposi dovettero, però, starsene in un dorato e neutrale
esilio in Pavia - invece lo zio, il re Ferdinando, forte del suo regno
di Napoli, pretendeva che la sua nipote avesse una sorte migliore ai vertici
del ducato -. Galeazzo
Maria Sforza tentò di continuare la politica paterna e mantenne
anche buone relazioni con gli alleati, privilegiando la Francia; e non
mancava di buone qualità. Ma, oltre il confronto con l’alta figura
del padre, gli nuocevano i modi superbi e la dissolutezza della vita.
Pesò sul fisco inasprendo le tasse, sbagliò grossolanamente
politica estera con Venezia e con i Fiorentini - era il tempo del famoso
Lorenzo il Magnifico -, non ascoltava la voce dei consiglieri più
quotati: il tutto sfociò in una congiura di nobili milanesi già
suoi amici, ai quali si aggiunsero gli avversari anche per risentimenti
personali. Il duca Galeazzo Maria cadde pugnalato nella chiesa di Santo
Stefano il 26 dicembre 1476. Si riapriva la crisi del ducato. Il suo figlio,
Gian Galeazzo II° aveva sette anni. Rimanevano in vita come
pretendenti i cognati di Bona: Sforza Maria, Lodovico il Moro, Ottaviano,
Ascanio. Lodovico il Moro era il più intemperante, aveva 26 anni,
brillante, furbo, tenace, machiavellico: tutti lo davano come l’aspirante
focoso al ducato, a tal punto che chiese alla vedova, Bona di Savoia,
sua cognata, di aiutarla nel comando e nell’amministrazione: ella acconsentì;
in tal modo i destini si maturavano tragicamente: il segretario Cicco
Simonetta fu decapitato; Bona di Savoia dovette ritirarsi nel castello
di Abbiategrasso; il figlio Gian Galeazzo che era il legittimo duca fu
relegato a vivere la giovinezza nel castello di Pavia, sotto la buona
cospirazione tutelativa dello zio Lodovico il Moro, colui che seppe aspettare
e riemergere dalla frana del ducato. Nel 1480 era l’incontrastato dominatore,
dopo due anni di reggenza collettiva. Lodovico il Moro celebrò
le nozze con Beatrice d’Este, figlia del duca di Ferrara; ottenne il riconoscimento
del titolo di duca dall’imperatore Massimiliano d’Asburgo, ad onore del
quale chiamò con lo stesso nome di Massimiliano il suo figlio primogenito;
mentre procurò al giovane nipote Gian Galeazzo, relegato in Pavia,
un clamoroso matrimonio con Isabella d’Aragona, coltissima ed affascin
ante: i due sposi dovettero, però, starsene in un dorato e neutrale
esilio in Pavia - invece lo zio, il re Ferdinando, forte del suo regno
di Napoli, pretendeva che la sua nipote avesse una sorte migliore ai vertici
del ducato -.
Le invasioni straniere contro
il ducato
Già dal secolo XIII la
politica francese si era volta verso l’Italia: ai sovrani francesi si era
appoggiato il papato quando la Germania non gli aveva più offerto
sostegno sicuro; poi l’Italia meridionale era caduta sotto la dominazione
di una famiglia francese; alla Francia si appoggiava Firenze per le esigenze
dei suoi commerci; altrettanto faceva il ducato di Savoia che, d’altra
parte, era di origine francese; la repubblica di Genova aveva più
volte cercato un suo dominio francese; infine il matrimonio di Valentina
Visconti con un principe della Casa di Orleans, avvenuto nel 1389, aveva
permesso ai re francesi, dopo la morte di Filippo
Maria, di vantare diritti sul ducato milanese. A questo si aggiungeva
che la Francia, nel suo organizzarsi e consolidarsi in forma di monarchia
assoluta sotto re di notevole personalità, rimaneva debole dal punto
di vista industriale e commerciale: i suoi commerci dipendevano infatti
in gran parte dalle repubbliche marinare italiane, e dagli operosi Comuni
essa importava gran quantità di manufatti. La conquista sicura e
incontrastata dell’Italia meridionale ed il dominio della Lombardia avrebbero
dunque dato, a quanto sembrava, un grande incremento economico alla Francia.
Le decisioni di Lodo vico il
Moro
La politica estera di Lodovico
il Moro portò alla rovina dell’Italia.  Egli
si sentiva attaccato dal re di Napoli, mentre Venezia era sempre in agguato
e contro ogni novità milanese. La psicosi di dover difendersi a
tutti i costi spinse Lodovico il Moro a chiamare in Italia il potente
re francese, Carlo VIII°, il quale venne, fu rice-vuto fastosamente
da Lodovico il Moro e giunse in pochi mesi alla conquista di Napoli, il
febbraio 1495. Un mese dopo circa dall’ingresso di Carlo VIII°
in Napoli gli Stati italiani capirono il grave sbaglio di aver lasciato
libero il passaggio ad uno straniero. Ancora sotto l’impressione delle
facili conquiste francesi stipularono una Lega il 31 marzo 1495. Già
Venezia si era avvicinata agli altri Stati italiani ed aveva mandato ambasciatori
in tutte le parti, compreso il ducato di Milano. Sul ponte del Lambro
in Melegnano avvenne la solenne accoglienza degli inviati del duca all’ambasciata
veneta capeggiata da Sebastiano Badoer e Benedetto Trevisan, avvocati
della Repubblica veneta, il 30 novembre 1494. Carlo VIII° potè
ritornare precipitosamente in Francia, con tutte le sue truppe, dopo essersi
riconciliato con il Moro ed aver ottenuto assicurazioni per una futura
probabile riconquista di Napoli. Evidentemente il Moro aveva fatto
una pace separata con i Francesi, tradendo gli alleati della Lega. In
tal modo stava sempre più complicando la sua posizione politica
che presto lo porterà alla rovina. Carlo VIII° moriva,
senza figli, nell’aprile 1498 con i suoi sogni di gloria. Ma a lui succedeva
il duca d’Orleans, quel famoso nipote di Valentina Visconti, il quale
considerava senza mezzi termini come sua legittima eredità il ducato
di Milano e intendeva riaverlo a tutti i costi. Il duca si chiamava, per
la storia, Luigi XII°. Questa volta furono i Veneziani a chiamare
in Italia i Francesi, i quali non si fecero aspettare. Luigi XII°,
che appena assunto al trono francese si era fatto chiamare anche con i
titoli di re di Napoli e di duca di Milano, scendeva in Italia nel 1499
invadendo subito la parte occidentale del ducato milanese, mentre le truppe
veneziane penetravano da oriente e si spingevano fino nel Lodigiano.
In questa guerra Melegnano fu colpita nel cuore. Un cronista del 1500,
Ambrogio da Paullo, lascia questa descrizione: “L’anno 1500 sul finire
di marzo si aveva una grande paura a causa delle truppe francesi che avevano
occupato Lodi e saccheggiato Riozzo... il 27 maggio 1502 l’esercito
francese di Luigi XII° è in marcia da Milano a Lodi si ferma
nei villaggi ruba ogni bene degli abitanti...”. Tutti i nostri paesi
e paesini davano l’allarme tra di loro trasmettendo il pericolo con il
suono delle campane a martello. Lodovico il Moro fuggiva in Germania,
abbandonato da tutti, dopo la catastrofe di Novara del 10 aprile 1500,
travestito da svizzero. Fu però riconosciuto e preso e trasportato
in Francia dove morì il 27 maggio 1508 anch’egli sognando impossibili
riconquiste e nuovi fasti gloriosi politici e diplomatici. Il re francese
Luigi XII° rimase il vero padrone del Milanese. Egli
si sentiva attaccato dal re di Napoli, mentre Venezia era sempre in agguato
e contro ogni novità milanese. La psicosi di dover difendersi a
tutti i costi spinse Lodovico il Moro a chiamare in Italia il potente
re francese, Carlo VIII°, il quale venne, fu rice-vuto fastosamente
da Lodovico il Moro e giunse in pochi mesi alla conquista di Napoli, il
febbraio 1495. Un mese dopo circa dall’ingresso di Carlo VIII°
in Napoli gli Stati italiani capirono il grave sbaglio di aver lasciato
libero il passaggio ad uno straniero. Ancora sotto l’impressione delle
facili conquiste francesi stipularono una Lega il 31 marzo 1495. Già
Venezia si era avvicinata agli altri Stati italiani ed aveva mandato ambasciatori
in tutte le parti, compreso il ducato di Milano. Sul ponte del Lambro
in Melegnano avvenne la solenne accoglienza degli inviati del duca all’ambasciata
veneta capeggiata da Sebastiano Badoer e Benedetto Trevisan, avvocati
della Repubblica veneta, il 30 novembre 1494. Carlo VIII° potè
ritornare precipitosamente in Francia, con tutte le sue truppe, dopo essersi
riconciliato con il Moro ed aver ottenuto assicurazioni per una futura
probabile riconquista di Napoli. Evidentemente il Moro aveva fatto
una pace separata con i Francesi, tradendo gli alleati della Lega. In
tal modo stava sempre più complicando la sua posizione politica
che presto lo porterà alla rovina. Carlo VIII° moriva,
senza figli, nell’aprile 1498 con i suoi sogni di gloria. Ma a lui succedeva
il duca d’Orleans, quel famoso nipote di Valentina Visconti, il quale
considerava senza mezzi termini come sua legittima eredità il ducato
di Milano e intendeva riaverlo a tutti i costi. Il duca si chiamava, per
la storia, Luigi XII°. Questa volta furono i Veneziani a chiamare
in Italia i Francesi, i quali non si fecero aspettare. Luigi XII°,
che appena assunto al trono francese si era fatto chiamare anche con i
titoli di re di Napoli e di duca di Milano, scendeva in Italia nel 1499
invadendo subito la parte occidentale del ducato milanese, mentre le truppe
veneziane penetravano da oriente e si spingevano fino nel Lodigiano.
In questa guerra Melegnano fu colpita nel cuore. Un cronista del 1500,
Ambrogio da Paullo, lascia questa descrizione: “L’anno 1500 sul finire
di marzo si aveva una grande paura a causa delle truppe francesi che avevano
occupato Lodi e saccheggiato Riozzo... il 27 maggio 1502 l’esercito
francese di Luigi XII° è in marcia da Milano a Lodi si ferma
nei villaggi ruba ogni bene degli abitanti...”. Tutti i nostri paesi
e paesini davano l’allarme tra di loro trasmettendo il pericolo con il
suono delle campane a martello. Lodovico il Moro fuggiva in Germania,
abbandonato da tutti, dopo la catastrofe di Novara del 10 aprile 1500,
travestito da svizzero. Fu però riconosciuto e preso e trasportato
in Francia dove morì il 27 maggio 1508 anch’egli sognando impossibili
riconquiste e nuovi fasti gloriosi politici e diplomatici. Il re francese
Luigi XII° rimase il vero padrone del Milanese.
La fine di una trionfale età
Nel periodo sforzesco l’economia
fu aiutata, le scienze si avviarono ad un buon sviluppo, grandi personalità
in ogni settore furono membri di una corte principesca tra le prime d’Europa.
Bernardino Corio, storico di Milano del periodo di Lodovico il Moro ci
lascia scritto: “qui vi sono storici, umanisti e poeti, architetti e pittori
fisici ed astronomi o molte di queste cose insieme... eccellentissimi in
tutte le arti e scienze”. Basterebbero i nomi di Leonardo da Vinci
e di Bramante da Urbino, di Francesco Filelfo e di Giorgio Merula, di Ermolao
Barbaro e di Demetrio Calcondila, di Gaspare Visconti e di Pier Candido
Decembrio per rappresentare una civiltà milanese nel ruolo di primo
piano in campo letterario ed artistico, sulla scia luminosa del Rinascimento
italiano.
L’ultima fiammata sforzesca
Luigi XII°, padrone del
Milanese, passava di vittoria in vittoria. Perfino contro l’eterna
nemica dei Milanesi, Venezia, riportò una clamorosa vittoria ad
Agnadello nel maggio del 1509. Ma al soglio pontificio sali un uomo
energico ed antifrancese: Giulio II°, il quale fece del suo programma
politico una missione contro la Francia, al grido di fuori i barbari! La
lega che egli potè stringere con gli Svizzeri, la Spagna, l’Inghilterra
e perfino con i Veneziani fu detta Lega Santa: e fu inevitabilmente la
guerra, nella quale gli Svizzeri poterono invadere tutto il Milanese fino
alla conquista di Milano che fu occupata nel giugno del 1512, avendo alla
testa il vescovo Matteo Schiner, detto il cardinale di Sion, dal nome di
una cittadina svizzera. La città di Milano fu consegnata ad
Ottaviano Sforza, figlio di Galeazzo Maria. Ottaviano era vescovo di Lodi
ed entrò in Milano come inviato speciale della Lega Santa insieme
con gli Svizzeri.
Francesco Brivio capitano e
vicario in Melegnano
Subito iniziarono le fasi per
la restaurazione materiale e politica del ducato. Francesco Brivio, membro
di una nobile famiglia milanese, offrì ad Ottaviano Sforza, il 19
luglio 1512, la somma di mille ducati, cinquecento subito e cinquecento
quando potesse avere come ipoteca il castello di Melegnano con la carica
di capitano e di vicario ducale, unitamente allo stipendio e a tutte le
prerogative che tale carica comportava e fruttificava. La tesoreria ducale
avrebbe sempre avuto la possibilità di riscattare il castello quando
avesse avuto la somma da restituire. Il 22 luglio fu spedito l’atto notarile
steso dal notaio imperiale Giulio Cattaneo ed il castello fu consegnato
al Brivio.
Francesco Brivio feudatario
di Mele gnano
Questa concessione finanziaria
del Brivio ebbe una importante conseguenza per Melegnano. Difatti, essendo
diventato duca Massimiliano Sforza, figlio di Lodovico il Moro, il Brivio
ebbe per sè‚ e per i suoi discendenti maschi legittimi, per sempre,
il territorio melegnanese con il castello, come un feudo, in data 15 dicembre
1513. Il nuovo assetto di Melegnano fu una grossa novità politica,
economica e sociale. Francesco Brivio ebbe tutti i legittimi poteri, le
spettanze e le competenze sui luoghi che prima erano della Camera ducale.
A lui fu concessa la facoltà di giudicare le cause civili e penali,
di riscuotere le tasse sul sale e sugli attrezzi di ferramenta. Rimanevano
esclusi gli edifici stabiliti per gli alloggiamenti dei cavalli. Ed il
tutto era regolato da precise clausole stese da diretto pugno del duca.
Il duca inviò pure un decreto agli abitanti di Melegnano ed in modo
particolare ai responsabili dell’amministrazione perchè‚ accettassero
e riconoscessero come loro feudatario Francesco Brivio, conte e tesoriere
del duca, e prestassero il giuramento di fedeltà. Difatti l’8 settembre
1514, due giorni dopo del decreto del duca, gli abitanti di Melegnano prestarono
il loro giuramento. A sua volta Francesco Brivio prestò solenne
giuramento al duca Massimiliano Sforza l’8 gennaio 1515. Pare che gli anni
della gestione del Brivio in Melegnano fossero sereni e nella normalità.
Quando morì ebbe la successione il figlio Dionigi. Egli dovette
subire la terribile situazione della seconda calata dei Francesi in Italia
e fu testimone della terribile battaglia dei Giganti del settembre 1515.
La Lombardia subì la dominazione straniera fino al 1521, quando
Gerolamo Morone, con l’aiuto degli Spagnoli, governò Milano, in
qualità di vicario del duca Francesco II°, che potè‚
riavere il ducato dei suoi avi. Egli morì il 1° novembre 1535,
all’età di quarant’anni senza lasciare eredi. Il governo del
ducato, ormai nella sfera degli Spagnoli, fu affidato al governatore Antonio
de Leyva. |
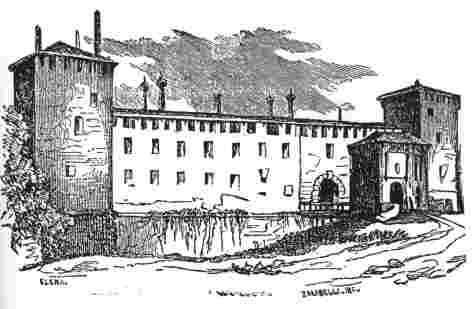 La
sorte del castello di Melegnano
La
sorte del castello di Melegnano