 |
 |
 |
In passato l'oca (Anser anser) era uno degli animali da cortile allevati dalla gente del popolo per la produzione di grasso da impiegare come condimento, da solo o mischiato con grasso di maiale. La gastronomia d’élite invece ne ricercava il fegato per la preparazione del paté, celebrato sino dal periodo imperiale romano (i Romani nutrivano le oche con fichi per fare loro ingrossare il fegato, iecur, che diveniva così iecur ficatum, da cui il nostro termine fegato). Nel mondo contadino l’oca rivestiva un’importanza rituale negli ambiti della propiziazione, che ne faceva uno degli alimenti ricorrenti in particolari festività: nel Nord della Francia era ricercato per i matrimoni; in Germania e in Boemia si mangiava per San Martino (11 novembre), in Inghilterra per San Michele (29 settembre), in Lombardia per San Siro (9 dicembre) e per San Silvestro, nelle Marche e in Umbria per Ognissanti. In tutta Europa costituiva una delle attrazioni delle fiere di paese il cruento gioco rituale del tiro dell’oca in cui i giovani dovevano riuscire a staccare la testa del pennuto vivo, appeso per i piedi ai rami di un albero, saltando o passandogli sotto a cavallo. Fu particolarmente apprezzata nelle zone con comunità ebraiche molto numerose, dove rivestiva un ruolo simile a quello occupato del maiale nella cultura cristiana. Nella fascia prealpina l’oca, molto rara in passato, era oggetto di allevamento sporadico a livello familiare. Se ne sfruttavano particolarmente per il grasso e la piuma, mentre le carni si cucinavano più o meno come quelle dei polli. Ancora oggi le oche sono allevate in numero limitatissimo, in Lombardia, soprattutto nella zona di Mortara, e il mercato italiano si avvale per lo più di capi provenienti dall’estero, proponendoli come specialità, a prezzi solitamente elevati. La tradizione lombarda rischia così di perdere (oltre alla salumeria anserina: salami e salamelle, prosciutti e ciccioli) alcuni dei suoi monumenti gastronomici: l’oca arrosto e quella ripiena di marroni e salsiccia, con (o senza) contorno di prugne; l’oca con i fagioli borlotti della Lomellina e quella in salmì del Comasco (per non parlare delle fricassee di lingue d’oche descritte nel ‘500 da Bartolomeo Scappi nella sua Opera).
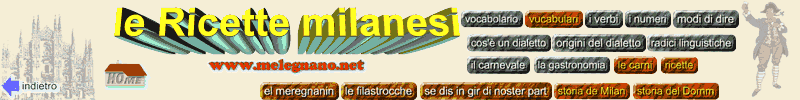 ...
...