
La Cascina Sarmazzano

 |
Vizzolo
Predabissi
La Cascina Sarmazzano |
 |
 Nell'ambito
delle indagini sulle dimore rurali in Italia promosse dal Consiglio Nazionale
delle Ricerche, gli studiosi dividono l'attuale Lombardia in cinque zone.
A quella della Bassa e la fascia dei fontanili corrispondono una serie
di medie e grandi aziende agricole, caratterizzate sotto il profilo tecnico,
da corti monoaziendali con grandi aie. Le dimore rurali corrispondono a
zone idrologiche, climatiche e litologiche oltre che alle particolari condizioni
economico-finanziarie che molto spesso derivano da scelte pregresse d'altri
tempi che sfruttavano al meglio essenzialmente le condizioni fisiche
del terreno. Il territorio in cui oggi si trova la cascina Sarmazzano "Sarmasàn"
prende il nome dal popolo dei "Sarmati", alleati dei Longobardi che, provenienti
dall'Europa orientale con i Bulgari e i Gepidi, si stanziarono qui nel
VI sec. Le indagini archivistiche condotte finora presso l'Archivio di
Stato, in particolare sul Fondo Agricoltura , Fondo Religione e Catasto
Teresiano, relative a tutta l'area del comprensorio melegnanese, hanno
prodotto diverse conferme circa la ricostruzione delle vicende storiche
relative agli insediamenti agricoli. La tipica forma a corte chiusa della
"casa da massaro" o "cassina" nasce nella seconda metà del Seicento,
la sua trasformazione da una forma semplice ad una più complessa
testimonia un ampliamento delle sue funzioni e un incremento delle
attività economiche ad essa collegate, che potrebbe apparire in
contrasto col quadro storico del Seicento italiano, e lombardo in particolare
. Questa situazione fu condizionata fortemente da diversi fattori quali:
la dominazione spagnola a partire dal 1559, il crollo del settore agricolo
nella seconda metà del XVI sec., la crisi industriale e mercantile
ormai evidente dal primo ventennio del Seicento. Il trattato di Cateau-Cambr‚sis,
ponendo gran parte dell'Italia , fra cui il Ducato di Milano, sotto il
dominio diretto del re di Spagna, apre le porte a una dominazione caratterizzata
da un forte fiscalismo, dovuto anche alle condizioni economiche particolarmente
critiche della Spagna stessa e alle guerre sostenute per la successione
del Monferrato e Mantova e dalla guerra per il controllo della Valtellina.
Le conseguenze più vistose di tale politica furono il rallentamento
della circolazione monetaria e la diminuzione delle attività manifatturiere
che produssero una riconversione dei capitali verso la terra, considerata
un bene-rifugio. Nel Ducato di Milano, fino alla prima metà del
Seicento, possiamo verificare statisticamente situazioni di decremento
demografico (la popolazione milanese passa in questo periodo da 1.200.000
a 800.000 abitanti) e di stasi del quadro colturale relativamente alle
tecniche agricole, alla produttività del suolo, all'introduzione
di nuove colture. E' quindi in questo periodo di crisi agricola che si
rilevarono numerose testimonianze di vagabondaggio e di banditismo
nelle campagne della Bassa. La cascina che fino a questo momento presentava
prevalentemente una disposizione su due lati, viene arricchita di edifici
funzionali alle accresciute attività agricole e casearie compiendo
la trasformazione architettonica con la tipica chiusura a corte dell'intero
perimetro con l'aggiunta di fortificazioni che per la cascina Sarmazzano
divenne di fondamentale importanza. Il complesso rurale, della "cascina
Sarmazzano", nella sua fattispecie originaria, fu nell'anno 880
di proprietà del monastero di Sant'Ambrogio, passando successivamente
ai monaci Umiliati. E' con l'ordine monastico degli Umiliati che il possedimento
di Sarmazzano iniziò irreversibilmente la sua decadenza strutturale. Nell'ambito
delle indagini sulle dimore rurali in Italia promosse dal Consiglio Nazionale
delle Ricerche, gli studiosi dividono l'attuale Lombardia in cinque zone.
A quella della Bassa e la fascia dei fontanili corrispondono una serie
di medie e grandi aziende agricole, caratterizzate sotto il profilo tecnico,
da corti monoaziendali con grandi aie. Le dimore rurali corrispondono a
zone idrologiche, climatiche e litologiche oltre che alle particolari condizioni
economico-finanziarie che molto spesso derivano da scelte pregresse d'altri
tempi che sfruttavano al meglio essenzialmente le condizioni fisiche
del terreno. Il territorio in cui oggi si trova la cascina Sarmazzano "Sarmasàn"
prende il nome dal popolo dei "Sarmati", alleati dei Longobardi che, provenienti
dall'Europa orientale con i Bulgari e i Gepidi, si stanziarono qui nel
VI sec. Le indagini archivistiche condotte finora presso l'Archivio di
Stato, in particolare sul Fondo Agricoltura , Fondo Religione e Catasto
Teresiano, relative a tutta l'area del comprensorio melegnanese, hanno
prodotto diverse conferme circa la ricostruzione delle vicende storiche
relative agli insediamenti agricoli. La tipica forma a corte chiusa della
"casa da massaro" o "cassina" nasce nella seconda metà del Seicento,
la sua trasformazione da una forma semplice ad una più complessa
testimonia un ampliamento delle sue funzioni e un incremento delle
attività economiche ad essa collegate, che potrebbe apparire in
contrasto col quadro storico del Seicento italiano, e lombardo in particolare
. Questa situazione fu condizionata fortemente da diversi fattori quali:
la dominazione spagnola a partire dal 1559, il crollo del settore agricolo
nella seconda metà del XVI sec., la crisi industriale e mercantile
ormai evidente dal primo ventennio del Seicento. Il trattato di Cateau-Cambr‚sis,
ponendo gran parte dell'Italia , fra cui il Ducato di Milano, sotto il
dominio diretto del re di Spagna, apre le porte a una dominazione caratterizzata
da un forte fiscalismo, dovuto anche alle condizioni economiche particolarmente
critiche della Spagna stessa e alle guerre sostenute per la successione
del Monferrato e Mantova e dalla guerra per il controllo della Valtellina.
Le conseguenze più vistose di tale politica furono il rallentamento
della circolazione monetaria e la diminuzione delle attività manifatturiere
che produssero una riconversione dei capitali verso la terra, considerata
un bene-rifugio. Nel Ducato di Milano, fino alla prima metà del
Seicento, possiamo verificare statisticamente situazioni di decremento
demografico (la popolazione milanese passa in questo periodo da 1.200.000
a 800.000 abitanti) e di stasi del quadro colturale relativamente alle
tecniche agricole, alla produttività del suolo, all'introduzione
di nuove colture. E' quindi in questo periodo di crisi agricola che si
rilevarono numerose testimonianze di vagabondaggio e di banditismo
nelle campagne della Bassa. La cascina che fino a questo momento presentava
prevalentemente una disposizione su due lati, viene arricchita di edifici
funzionali alle accresciute attività agricole e casearie compiendo
la trasformazione architettonica con la tipica chiusura a corte dell'intero
perimetro con l'aggiunta di fortificazioni che per la cascina Sarmazzano
divenne di fondamentale importanza. Il complesso rurale, della "cascina
Sarmazzano", nella sua fattispecie originaria, fu nell'anno 880
di proprietà del monastero di Sant'Ambrogio, passando successivamente
ai monaci Umiliati. E' con l'ordine monastico degli Umiliati che il possedimento
di Sarmazzano iniziò irreversibilmente la sua decadenza strutturale. 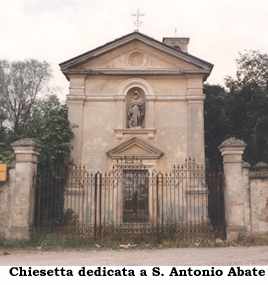 Fu
l'arcivescovo di Milano San Carlo Borromeo, paladino del nuovo movimento
di Controriforma promosso dal Concilio di Trento, che nel suo tentativo
complessivo di riformare l'ordine degli Umiliati che nel 1567
venne in visita pastorale alla comunità di Sarmazzano. San Carlo
in quell'occasione trovò la chiesa di San Protasio e Gervasio in
pessime condizioni, priva del pavimento, delle porte e di ogni paramento,
e vi si celebrava messa solo una volta all'anno nel giorno appunto della
festa dei santi a cui era dedicata. Per provvedere alle spese di restauro,
l'Arcivescovo di Milano dovette ordinare il sequestro dei beni del prete
che l'aveva in affitto, come si usava a quel tempo, un tale magnifico signore
Bartolomeo Reina , che evidentemente, si preoccupava unicamente delle entrate
che gli venivano da quella chiesa. Il 7 febbraio 1571, il papa Pio V°
soppresse definitivamente l'ordine degli Umiliati, distribuendo le loro
vaste proprietà ad altre istituzioni religiose. In particolare la
Casa di Santa Maria degli Ottazi, cui appartenevano i beni di Sarmazzano,
venne trasformata in un ospedale per i vecchi per precisa volontà
di San Carlo Borromeo, il quale assegnò altresì i beni di
Sarmazzano ai Padri Oblati del Santo Sepolcro. La struttura della cascina
subì nel corso dei secoli diversi rimaneggiamenti testimoniati dai
diversi stili tutt'ora riscontrabili nel plesso: una enorme stalla a cinque
navate con finestroni neo-gotici - e un tetto forse più grande
della zona - chiude il lato meridionale di una vasta corte rettangolare,
orientata a nord-sud; sul lato settentrionale esiste una piccola corte
per i salariati. Tale stalla si affianca all'ingresso, sovrastato da una
torre non molto alta, che dà l'impressione di una volontà
di fortificazione, più che di difesa effettiva. A fianco dell'ingresso
sulla sinistra, sempre all'esterno, rinchiusa da una recinzione in ferro
battuto, é situata, una chiesetta con una facciatina in stile
classicheggiante dedicata a Sant'Antonio, protettore degli allevatori.
Questo edificio fu costruito nella seconda metà dell'Ottocento in
luogo di un'oratorio più antico che era dedicato ai Santi Gervasio
e Protasio. Nel 1751 la seconda Giunta del Censimento presieduta da Pompeo
Neri iniziò la descrizione dei beni di seconda stazione nel
territorio di Sarmazzano. L'inventario dei beni immobiliari fu steso dal
perito Giovanni Battista Ratti coadiuvato dal Console (Sindaco) di Sarmazzano
Pietro Brunetti. I suddetti beni erano tutti di proprietà del "Colleggio
d'Obblati in S.Sepolcro di Milano", analiticamente erano: al fondo n. 59
casa con orto; al fondo n.60 casa da Massaro in mappa alla lettera B; fondo
n.61 casa con Mulino in mappa al numero 17 compreso di orto. Nel 1751 l'amministrazione
austriaca decise di aggregare Sarmazzano, che all'epoca disponeva un'estensione
agricola di 1705 pertiche milanesi, alle comunità di Calvenzano
e Vizzolo per la formazione di un nuovo Comune , con Decreto della Real
Giunta del Governo in data 8 febbraio 1757. La cascina Sarmazzano nel 1929
fu concessa in affitto alla famiglia Novazzi, che la condusse sino all'inizio
degli anni Sessanta; allora vi abitavano circa trenta famiglie composte
da contadini, falegnami e mungitori, e si allevavano più di 200
capi tra bovini , cavalli e tori. I Salariati, con contratto annuale, lavoravano
dalle sei alle undici ore giornaliere, secondo i ritmi dei lavori stagionali
e le ore di luce. Ricevevano un litro di latte al giorno e, durante la
raccolta di mais, un sacco su ogni otto consegnati al padrone e alcuni
quintali di legna verde per l'inverno. Fu
l'arcivescovo di Milano San Carlo Borromeo, paladino del nuovo movimento
di Controriforma promosso dal Concilio di Trento, che nel suo tentativo
complessivo di riformare l'ordine degli Umiliati che nel 1567
venne in visita pastorale alla comunità di Sarmazzano. San Carlo
in quell'occasione trovò la chiesa di San Protasio e Gervasio in
pessime condizioni, priva del pavimento, delle porte e di ogni paramento,
e vi si celebrava messa solo una volta all'anno nel giorno appunto della
festa dei santi a cui era dedicata. Per provvedere alle spese di restauro,
l'Arcivescovo di Milano dovette ordinare il sequestro dei beni del prete
che l'aveva in affitto, come si usava a quel tempo, un tale magnifico signore
Bartolomeo Reina , che evidentemente, si preoccupava unicamente delle entrate
che gli venivano da quella chiesa. Il 7 febbraio 1571, il papa Pio V°
soppresse definitivamente l'ordine degli Umiliati, distribuendo le loro
vaste proprietà ad altre istituzioni religiose. In particolare la
Casa di Santa Maria degli Ottazi, cui appartenevano i beni di Sarmazzano,
venne trasformata in un ospedale per i vecchi per precisa volontà
di San Carlo Borromeo, il quale assegnò altresì i beni di
Sarmazzano ai Padri Oblati del Santo Sepolcro. La struttura della cascina
subì nel corso dei secoli diversi rimaneggiamenti testimoniati dai
diversi stili tutt'ora riscontrabili nel plesso: una enorme stalla a cinque
navate con finestroni neo-gotici - e un tetto forse più grande
della zona - chiude il lato meridionale di una vasta corte rettangolare,
orientata a nord-sud; sul lato settentrionale esiste una piccola corte
per i salariati. Tale stalla si affianca all'ingresso, sovrastato da una
torre non molto alta, che dà l'impressione di una volontà
di fortificazione, più che di difesa effettiva. A fianco dell'ingresso
sulla sinistra, sempre all'esterno, rinchiusa da una recinzione in ferro
battuto, é situata, una chiesetta con una facciatina in stile
classicheggiante dedicata a Sant'Antonio, protettore degli allevatori.
Questo edificio fu costruito nella seconda metà dell'Ottocento in
luogo di un'oratorio più antico che era dedicato ai Santi Gervasio
e Protasio. Nel 1751 la seconda Giunta del Censimento presieduta da Pompeo
Neri iniziò la descrizione dei beni di seconda stazione nel
territorio di Sarmazzano. L'inventario dei beni immobiliari fu steso dal
perito Giovanni Battista Ratti coadiuvato dal Console (Sindaco) di Sarmazzano
Pietro Brunetti. I suddetti beni erano tutti di proprietà del "Colleggio
d'Obblati in S.Sepolcro di Milano", analiticamente erano: al fondo n. 59
casa con orto; al fondo n.60 casa da Massaro in mappa alla lettera B; fondo
n.61 casa con Mulino in mappa al numero 17 compreso di orto. Nel 1751 l'amministrazione
austriaca decise di aggregare Sarmazzano, che all'epoca disponeva un'estensione
agricola di 1705 pertiche milanesi, alle comunità di Calvenzano
e Vizzolo per la formazione di un nuovo Comune , con Decreto della Real
Giunta del Governo in data 8 febbraio 1757. La cascina Sarmazzano nel 1929
fu concessa in affitto alla famiglia Novazzi, che la condusse sino all'inizio
degli anni Sessanta; allora vi abitavano circa trenta famiglie composte
da contadini, falegnami e mungitori, e si allevavano più di 200
capi tra bovini , cavalli e tori. I Salariati, con contratto annuale, lavoravano
dalle sei alle undici ore giornaliere, secondo i ritmi dei lavori stagionali
e le ore di luce. Ricevevano un litro di latte al giorno e, durante la
raccolta di mais, un sacco su ogni otto consegnati al padrone e alcuni
quintali di legna verde per l'inverno. |
